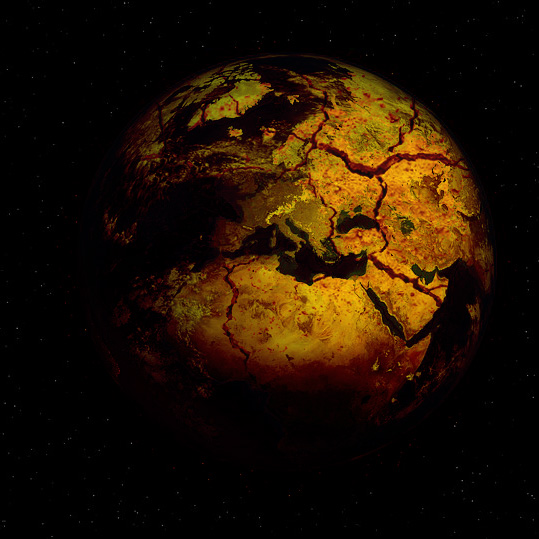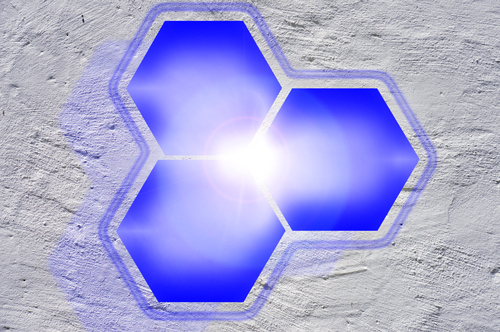Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, Jingle bells swing and jingle bells ring…
“Stanno arrivando?”
“Ma è ancora troppo presto!”
“Presto? Fuori non c’è più il sole, ci siamo ormai!”
“Mah, non credo.”
“Ssssh, piano, sta fermo, Thompson è qui! Vuoi farti scoprire?”
“Ma cosa vuoi che senta il vecchio, è sordo!”
“Appunto, è sordo, ma mica cieco!”
Il piccolo Pedone Bianco si zittì, sporgendosi dall’armadio dove si trovava la loro scacchiera; il Cavallo Nero con cui aveva parlato fino a poco prima nitrì innervosito, trottando verso i suoi Re e Regina. Possibile che fosse ancora così presto? La data segnata sul calendario era giusta, 24 dicembre, Vigilia di Natale. Allora perché non era ancora arrivato nessuno?
What a bright time, it’s the right time to rock the night away…
Il Signor Thompson batteva il tempo della canzone natalizia con il piede, un dolce tump tump tump sulla moquette di un colore verde militare sbiadito; aveva pulito tutta casa fino a poco prima, adesso si meritava una piccola pausa. Ci teneva a fare una bella figura con i suoi parenti!
Il Pedone Bianco non stava più nella pelle, voleva iniziare una partita al più presto: era da Pasqua che il vecchio Thompson non tirava giù la vecchia scacchiera dall’armadio. Bianchi e Neri, seppur a malincuore, si erano abituati alla loro nuova vita fatta di poche battaglie e tante attese; purtroppo, da quando l’amatissima Signora Thompson se ne era andata, il padrone di casa non se la sentiva affatto di giocare da solo. Ma fortunatamente durante le feste, figli e nipoti si ritrovavano nella casa e subito gli tornava la voglia di giocare a scacchi.
Il piccolo Pedone Bianco avrebbe desiderato tantissimo che i nipoti del Signor Thompson passassero più spesso dal vecchio nonno per giocare assieme, ma vivevano lontani, sparsi per il grande globo: così, doveva accontentarsi solo delle feste.
“Meglio che niente,” sospirò, voltandosi verso i suoi compagni di scacchiera. Il suo Re e la sua Regina stavano sonnecchiando, ronfando beatamente cullati dalla canzone natalizia; nel frattempo, i due Cavalli Bianchi facevano una gara di velocità da un bordo all’altro della scacchiera, senza fare troppo rumore grazie alle loro estremità imbottite. Tump, tump, tump, il loro suono si confondeva con quello ovattato prodotto dal piede del Signor Thompson.
“Ancora nulla?” Bisbigliò l’Alfiere Bianco, avvicinandosi con cautela, “Cavallo Nero mi sembra nervoso oggi.”
“Forse perché ha paura di perdere, il ronzino,” ridacchiò la Torre Bianca, dando un colpetto di intesa al suo compagno.
Il Pedone Bianco guardò verso l’ingresso che si intravedeva dalle vetrate della porta del salotto, “ancora non si vede nessuno.”
“Mmm, forse c’è traffico. Sono solo le sette secondo mio fratello,” replicò l’Alfiere, “ha visto il vecchio guardare l’orologio da taschino poco fa.”
“Sicuro?”
“Così dice Alf!”
“Siate pazienti!” La voce della Regina Nera li interruppe. Si avvicinò con maestosità, con la sua corona che la rendeva ancora più alta e fiera. “Arriveranno, come sono sempre arrivati ad ogni festa. Penso sia ridicolo solo parlarne, miei cari.”
I tre pezzi bianchi si guardarono fra di loro poco convinti: nessuno comunque ebbe voglia di replicare alla regnate dei pezzi Neri, visto che solitamente erano sempre in conflitto e la Regina incuteva timore un po’ a tutti sulla scacchiera. Il Pedone Bianco preferiva di gran lunga la sua Regina Bianca, che il più delle volte dormiva e non possedeva quell’aria altezzosa.
La Regina Nera, capendo che non avrebbe ottenuto delle risposte, sbuffò e se tornò da dove era venuta; la Torre Bianca tirò un sospiro di sollievo, “pensavo non se ne andasse più! Non vedo l’ora di stracciarli dopo cena…”
“Sempre che il vecchio giochi con noi Bianchi,” l’Alfiere replicò, “se ci tocca giocare per il piccolo Johnny, siamo finiti.”
“Ehi, Johnny aveva 9 anni l’anno scorso. Adesso ne ha 10. Potrebbe andarci meglio, no? E poi il vecchio si sa che preferisce giocare con noi…”
“Uhm, ricordi male. Era la Signora Thompson che giocava con noi.”
La Torre rimase in silenzio per un attimo, valutando le parole dell’Alfiere. “Sicuro?”
Il Pedone Bianco mosse in avanti ed indietro la sua testolina tonda, per poi tornare a guardare verso l’ingresso speranzoso: in quel momento, il suono del campanello risuonò nella casa.
“CI SIAMO!” Esclamò eccitato, saltato sul posto, “CI SIAMO!”
I due sovrani Bianchi si svegliarono di soprassalto; i due Cavalli fermarono la loro corsa; i Pedoni guardarono il fratello incuriositi.
“Silenzio!” Il Cavallo Nero richiamò il Pedone Bianco, ma fu inutile: tutti adesso erano entusiasti dell’arrivo dei parenti Thompson.
Di fatto, il Signor Thompson si era alzato dalla poltrona ed era andato ad aprire la porta: un vociare indistinto di uomini e donne che si scambiavano gli auguri si udì fino in salotto. Due bambini furono i primi ad entrare nella casa del nonno, togliendosi le pesanti giacche invernali e lasciandole dimenticate sulla poltrona.
“Rose, Johnny, che cosa vi ho detto? Forza, mettete apposto le giacche!” La voce della madre Emily, nonché figlia del vecchio Thompson, era autoritaria e non ammetteva repliche. I due bambini non poterono far altro che riprendere le giacche e sistemarle con cura sull’appendiabiti.
La scacchiera era tutto un fremito.
“Dici che si metteranno a giocare presto?”
“Magari inizieranno prima della cena per scaldarsi un po’, no?”
“Oh, non vedo l’ora!”
“Ma lasciateli mangiare prima! Siete veramente assillanti certe volte…”
Il Pedone sospirò nel sentire il brusio dei suoi compagni di scacchiera: era ovvio che non avrebbero giocato prima della fine della cena. Ogni anno era sempre la stessa storia, c’era un copione perfetto da dover rispettare: presto si sarebbero seduti a tavola per mangiare insieme le prelibatezze del vecchio Thompson ed i bambini poi, avrebbero scartato i regali nell’entusiasmo generale…
“Nonno, possiamo giocare con la scacchiera?”
Il giovane pedone non poteva credere alle sue orecchie: stava accadendo davvero? La piccola Rose era andata a chiedere al nonno di prendere il loro piccolo campo di battaglia così presto?
“Vuoi già giocare?” Il Signor Thompson era rimasto stupefatto tanto quanto il pedone. “Ma certo!” Esclamò l’uomo con un gran sorriso.
“Oh, amici, ci siamo!” Bisbigliò il pedone, “ci siamo!”
Guardò rapito come le due grandi mani del Signor Thompson presero la scacchiera con attenzione, tirandola giù dal loro posto abituale. Della polvere si mosse intorno a loro, ma per il resto, le statuine erano immobili, fremendo segretamente dall’entusiasmo.
“Eccola qui,” fece il Signor Thompson, posandola sul tavolino posto in mezzo alle due poltrone del salotto. Il pedone si trattenne dal saltare dalla gioia: sembrava di essere tornati ai vecchi tempi! Venne preso da due piccole dita timide timide, per poi essere spolverato da un grande fazzolettone, “ecco, ecco, lucidiamole un po’!” Commentò il Signor Thompson, facendo ridere la piccola Rose.
Si sarebbe preannunciato un Natale favoloso…
Con questo breve racconto fine a sé stesso, vi auguro buon anno e ancora buone feste! Ci vediamo nel 2019, con nuovi articoli e racconti pronti per essere letti!